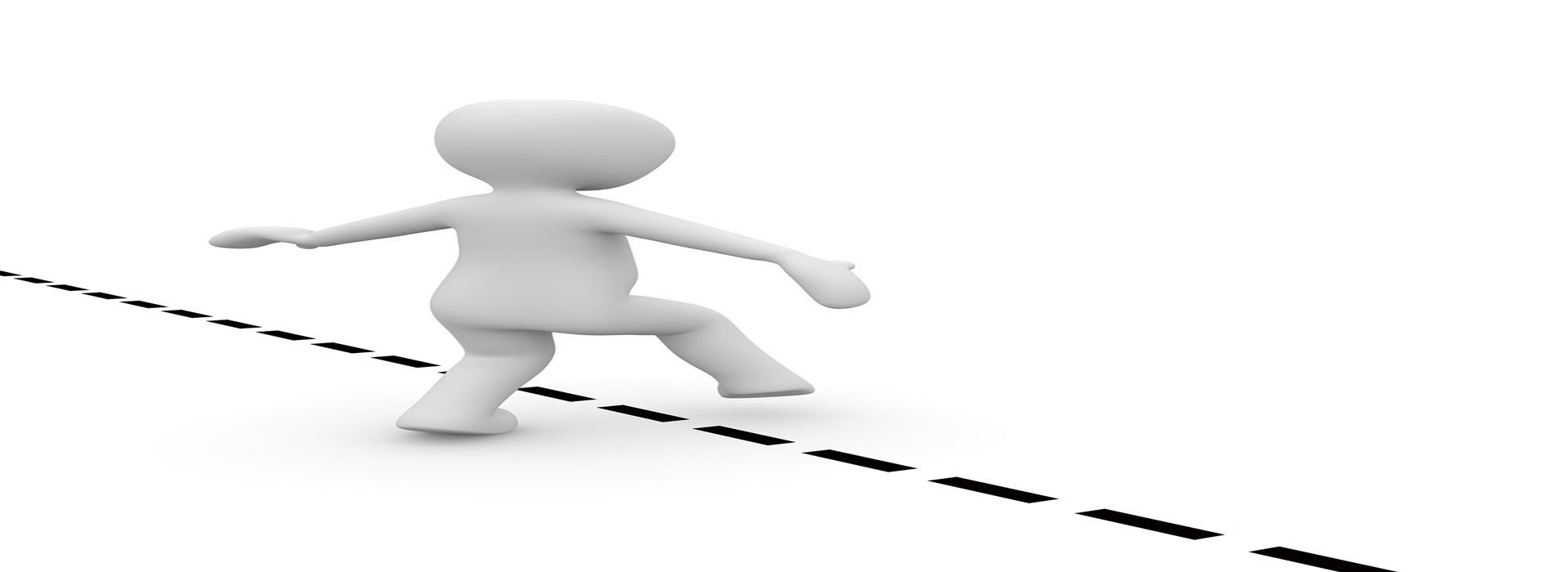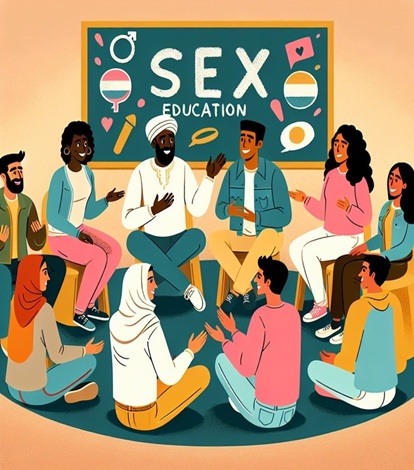Stefania Gigli
Psicoterapeuta
Il consenso sessuale
Il termine consenso è sempre stato un concetto chiave nei dibattiti femministi che riguardano la violenza di genere e quella sessuale. Bisogna però attendere fino alla nascita, nel 2017, del movimento #MeToo, movimento femminista che ha messo in evidenza la diffusione di molestie e violenze sessuali contro le donne nei luoghi di lavoro, perché ci si interroghi sull’importanza di questo concetto.
In generale, il consenso sessuale è quando due o più persone sono d’accordo ad avere un rapporto sessuale. Prestare il proprio consenso non significa solo scegliere, secondo una modalità̀ attiva, l’atto; può, infatti, esserci un’accettazione passiva di quanto non si sarebbe affatto scelto, dove condizioni esterne, o interne, ci impediscano di rifiutare.
Possiamo essere d’accordo perché sappiamo che il nostro partner insisterà a lungo per avere un rapporto, perché è il nostro lavoro ed è remunerato, perché abbiamo bisogno di contatto fisico con qualcuno, perché l’altro ci sembra solo, perché sembra che ne abbia voglia o semplicemente perché non vediamo motivi per cui dovremmo sottrarci ad averne uno.
Essere d’accordo significa essere d’accordo a cosa esattamente? Posso non essere d’accordo al sesso penetrativo ma ai preliminari. Potrebbe essere che io voglia dare il consenso solo per una specifica pratica sessuale mentre no a tutte le altre. Può anche accadere che io cambi idea durante l’atto sessuale.
Per verificare la fragilità della definizione precedente potremmo chiederci cosa significhi non dare il consenso ovvero quando non si è d’accordo ad avere un rapporto sessuale.
Non dare il consenso significa stupro? Si tende infatti a ricondurre il non consenso all’ambito dello straordinario e all’eccezionalità mentre sia questo è diffusissimo, sia sono molto diffusi ii rapporti sessuali non consenzienti.
Uno degli studi più importanti sulla consensualità di Gavey del 2005 evidenzia come siano frequenti i rapporti sessuali non consenzienti all’interno della coppia eterosessuale, sia nella forma di stupro coniugale sia come sesso estorto con minacce, ricatti, intimidazioni e manipolazioni.
Il consenso, dal punto di vista giuridico, mostra come sia centrale l’enunciazione di esso ma come essa difficilmente si mostra in maniera libera e consapevole.
I soggetti implicati in una relazione sessuale non sono tutti sullo stesso piano e non possono manifestare liberamente le proprie preferenze, avendo piena applicazione delle proprie intenzioni.
Esistono differenze di razza, di classe, di validità e di genere.
Poniamo attenzione alle ingiustizie di genere nella sessualità. Le donne vengono ancora educate più alla loro sottomissione che alla loro libertà basti pensare al lavoro di cura che caratterizza tutta la loro vita (figli e marito). Come si potrebbe quindi pensare che sia diverso all’interno di una relazione sessuale?
Sono presenti ancora pratiche sociali che vedono la donna che acconsente (o meno) e l’uomo che agisce, la donna oggetto e l’uomo che deve conquistarla. L’espressione “donna facile” presuppone che debba essere difficile conquistare una donna e che l’enunciazione di no faccia parte di un modello di relazione in cui la donna è conquista dell’uomo che è predatore.
Le disparità di genere, nella sessualità, causano altre forme di ingiustizia.
Infatti, se consideriamo il sesso come pratica sociale è chiaro che la sua rappresentazione seguirà l’ottica di coloro che hanno maggior potere nella società: gli uomini. Ciò implica che la produzione e la ricezione di tutte le conoscenze sessuali siano limitate ad un unico modello provocando così effetti nefasti sulle pratiche sessuali poiché non riconosciute da tutti.
Studi dimostrano che in situazioni minoritarie, le persone oppresse non solo si adattano alle scelte del gruppo maggioritario ma anche ai gusti.
Si apre così il dilemma dell’agentività, ovvero la difficoltà di riconoscere e analizzare la vulnerabilità delle persone oppresse pur riconoscendo e rispettando la loro capacità di agire.
Si deve quindi diffidare dall’idea che il consenso sia espressione di libertà poiché desideri e gusti sono prodotto di un’educazione discriminata dal genere e l’espressione di essi è mediata infatti da distorsioni sia nella recezione sia nella espressione.
In considerazione a tutti questi elementi arriviamo ad una nuova definizione di consenso. Esso è ciò che si muove quella zona grigia che va da ciò che non è pienamente consenziente e ciò che non è non pienamente non consenziente.
Solo attraverso questa definizione si individua la necessità di prestare attenzione a tutti i dettagli delle situazioni per legittimarle, a rispettare le ingiustizie di genere e preservare l’autonomia sessuale di tutti e tutte favorendo il dialogo. Il consenso dovrebbe essere visto quindi come la manifestazione dell’autonomia sessuale del partner che deve avvenire in maniera continuativa per tutta la durata del rapporto. Questo implica un’attenzione e un rispetto per l’altro, per la situazione in cui si trova, per le limitazioni che può avere, per i differenziali di potere o di autorità che possono esistere (Garcia, 2022). Il criterio di tutta la durata del rapporto è centrale poiché analizzando la complessità del desiderio è facile comprendere come non si può sapere con precisione che cosa si vuole o meno prima che si presenti il momento. Diventa quindi centrale il ruolo di scambi comunicativi nell’atto sessuale, visti come una conversazione più che una negoziazione, che sviluppi la collaborazione e la comunicazione tra i partner in maniera tale da accettare anche un eventuale temporaneo non-consenso. Questo permetterebbe di ottenere quindi una relazione sessuale che protegga l’autonomia, l’integrità sessuale, la soggettività e l’autonomia
BIBLIOGRAFIA
Hancock (2022), Consenso, possiamo parlarne? Ed. Settenove
Manon Garcia (2022), Di che cosa parliamo quando parliamo di consenso? Ed. Einaudi
Angel (2022), Il sesso che verrà, Black edizioni